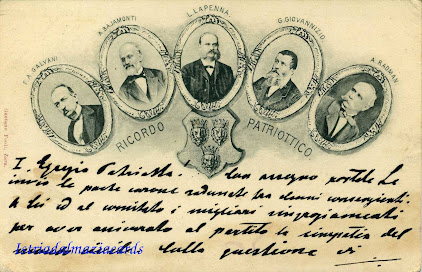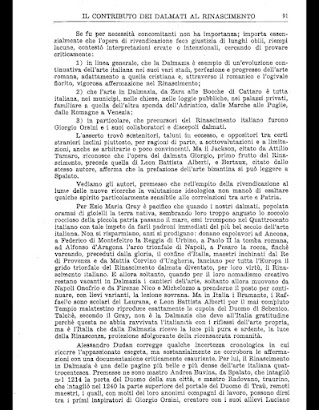O Miramare, a le tue bianche torri
attediate per lo ciel piovorno
fosche con volo di sinistri augelli
vengon le nubi.
Miramare, contro i tuoi graniti
grige dal torvo pelago salendo
con un rimbrotto d'anime crucciose
battono l'onde.
Meste ne l'ombra de le nubi a' golfi
stanno guardando le città turrite,
Muggia e Pirano ed Egida e Parenzo,
gemme del mare;
e tutte il mare spinge le mugghianti
collere a questo bastion di scogli
onde t'affacci a le due viste d'Adria,
rocca d'Absburgo;
e tona il cielo a Nabresina lungo
la ferrugigna costa, e di baleni
Trieste in fondo coronata il capo
leva tra' nembi.
Deh come tutto sorridea quel dolce
mattin d'aprile, quando usciva il biondo
imperatore, con la bella donna,
a navigare!
A lui dal volto placida raggiava
la maschia possa de l'impero: l'occhio
de la sua donna cerulo e superbo
iva su 'l mare.
Addio, castello pe' felici giorni
nido d'amore costruito in vano!
Altra su gli ermi oceani rapisce
aura gli sposi.
Lascian le sale con accesa speme
istoriate di trionfi e incise
di sapienza. Dante e Goethe al sire
parlano in vano
da le animose tavole: una sfinge
l'attrae con vista mobile su l'onde:
ei cede, e lascia aperto a mezzo il libro
del romanziero.
Oh non d'amore e d'avventura il canto
fia che l'accolga e suono di chitarre
là ne la Spagna de gli Aztechi! Quale
lunga su l'aure
vien da la trista punta di Salvore
nenia tra 'l roco piangere de' flutti ?
Cantano i morti veneti o le vecchie
fate istriane ?
— Ahi! mal tu sali sopra il mare nostro
figlio d'Absburgo, la fatal Novara.
Teco l'Erinni sale oscura e al vento
apre la vela.
Vedi la sfinge tramutar sembiante
a te d'avanti perfida arretrando!
il viso bianco di Giovanna pazza
contro tua moglie.
È il teschio mozzo contro te ghignante
d'Antonietta. Con i putridi occhi
in te fermati è l'irta faccia gialla
di Montezuma.
Tra boschi immani d'agavi non mai
mobili ad aura di benigno vento,
sta ne la sua piramide, vampante
livide fiamme
per la tenebra tropicale, il dio
Huitzilopotli, che il tuo sangue fiuta,
e navigando il pelago co 'l guardo
ulula — Vieni.
Quant'è che aspetto! La ferocia bianca
strussemi il regno ed i miei templi infranse:
vieni, devota vittima, o nepote
di Carlo quinto.
Non io gl'infami avoli tuoi di tabe
marcenti o arsi di regal furore;
te io voleva, io colgo te, rinato
fiore d'Absburgo;
e a la grand'alma di Guatimozino
regnante sotto il padiglion del sole
ti mando inferia, o puro, o forte, o bello
Massimiliano. —