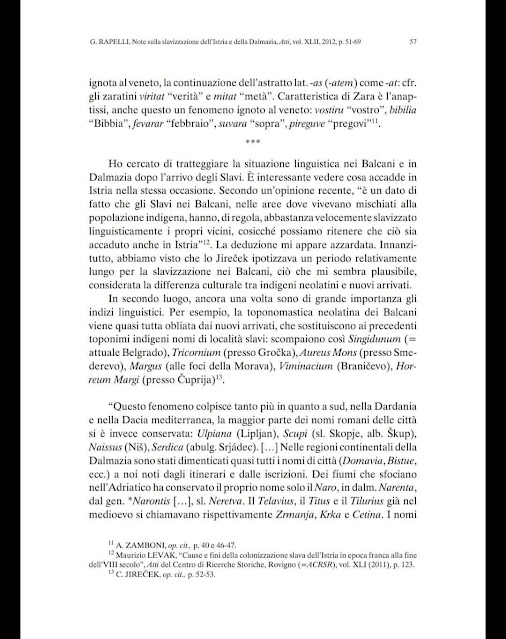In difesa dell'italianità dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia
mercoledì 8 novembre 2023
Max Fabiani
La letteratura italiana in Dalmazia. Una Storia falsificata
Nel lontano 1926, nella serie delle pubblicazioni dell’Accademia Jugoslava delle Arti e delle Scienze, fu pubblicata l’opera di Gjuro Kober dal titolo “Italijansko pjesniestvo u Dalmaciji 16 vijeka, napose u Kotoru i Dubrovniku” e cioé “Poesia italiana in Dalmazia nel XVI secolo, soprattutto a Cattaro e Ragusa”. Dopo quella data nessun studioso croato ha mai parlato di una poesia o di una letteratura italiana in Dalmazia nei secoli passati. Cominciò, invece, un processo che ha portato finora a colossali falsificazioni. In un articolo del 1969 lo storico della letteratura croata Andre Jutrovic scrisse: “Gli scrittori della Dalmazia che nel passato scrissero le loro opere in lingua italiana devono essere inseriti nella nostra letteratura e nella nostra storia nazionale”, definendoli “scrittori croati di lingua italiana”. Nell’ottobre del I993, sulle colonne del “Vjesnik” di Zagabria, il presidente dell’Associazione degli scrittori croati mi accusò di aver “trasformato in italiani tutta una serie di scrittori croati dell’antica Ragusa”, per aver riportato i nomi originali in italiano e latino delle loro opere. Un anonimo “illustre croato” per spiegare l’avversione che certi intellettuali croati nutrono verso l’Italia e gli italiani disse: “Siamo tanto affascinati dalla cultura italiana e la sentiamo così vicina che rischiamo di esserne compressi e plagiati, al punto da rinunciare alla nostra. Quando ci si spinge in questa direzione, allora l’amore può diventare odio”. E spinto dall’odio, qualcuno cerca di appropriarsi di ciò che non gli appartiene fino al punto di definire croato Marco Polo! Oppure da dichiarare “croato da sempre” - ossia quasi dall’inizio dell’umanità - ogni lembo dell’odierna Croazia che, invece, nel lontano e recente passato è stato abitato anche da italiani e “concimato” dalla cultura italiana e, ancor prima, da quella latina. Una volta falsificati, ovvero croatizzati, nome e cognome di uno scrittore, di un pittore, di un musicista che nacque o visse sul territorio che oggi fa parte della Croazia, la sua opera diventa automaticamente croata. Il poeta e musicologo istriano Andrea Antico, vissuto a Venezia, è diventato Andrija Starci e, grazie a lui, gli inizi della musica croata sono stati spostati al Cinquecento. Quando non si riesce a falsificare il cognome, si falsifica almeno il nome e allora il pittore fiumano dell’Ottocento Giovanni Simonetti diventa Ivan Simonetti. Quasi sempre, però, si segue la regola della contraffazione totale, nome e cognome, in modo da cancellare ogni traccia di italianità. Capita così che il filosofo di Cherso Francesco Patrizio (1529- 1597) venga via via rinominato dalla storiografia croata come Frane Patricije-Petric nel 1927 , Franjo Petric nel 1929 e poi, definitivamente, Frane Petric nel I960. In suo onore, quale “padre della filosofia croata”, vengono tenute a Cherso le “Giornate di Frane Petric”; giornate di un uomo inesistente! Non si può onorare un uomo togliendogli, o meglio falsificandogli, nome e cognome. Se Francesco Patrizio potesse risorgere dalla sua tomba maledirebbe i suoi falsificatori e tutti coloro che hanno affollato la storia della cultura croata con personaggi che nulla o pochissimo hanno a che fare con la cultura croata. Francesco Patrizio non scrisse in vita una sola riga in croato. Insomma Patrizio, ovvero Patritius come si firmava in latino, non fu mai Frane Petric, come vorrebbero i suoi contraffattori. La contraffazione della storia e l’appropriazione indebita da parte croata dei grandi nomi e delle grandi opere della cultura italiana in Istria-Dalmazia-Quarnaro è una vecchia/nuova forma di nazionalismo e sciovinismo. La frustrazione derivante da insufficienze culturali viene trasformata in miti di vittoria, dietro i quali si nascondono invidia e odio. Odio per l’Italia e gli italiani. Le offese portate al filosofo chersino, al musicista e poeta di Montona, al pittore fiumano e a tanti altri esponenti della cultura e dell’arte italiana nella regione istroquarnerina, ovvero nei territori che nel 1945 furono dichiarati “neoliberati”, sono la conseguenza di uno sforzo compiuto dai nuovi venuti per azzerare la storia di chi li ha preceduti e di riscrivere una storia diversa ad essi più conveniente; ma poiché in questi territori gli italiani, anche se pochi, sono rimasti, la distruzione della memoria non ha potuto essere totale. Invece in Dalmazia non si è salvato nessuno. A leggere i libri di storia e le storie della letteratura o dell’arte croati, si ha l’impressione che quella regione sia croata da almeno tremila anni: romani e veneziani furono soltanto dei temporanei invasori, ospiti senza radici e senza potere, senza lingua, senza scrittura e senza cultura. Mentre i contadini e popolani croati creavano sculture e opere pittoriche eccezionali fin dall’ottavo secolo e scrivevano libri di poesia, trattati di filosofia, opere scientifiche ecc., i patrizi e i cittadini romanici e italici, delle città costiere della Dalmazia e delle sue isole maggiori, facevano la parte di inetti spettatori, oppure offrivano la manovalanza, ignoranti e analfabeti com’erano. Avete mai letto in un libro croato di storia dell’arte dei capolavori di Giorgio Orsini, scultore ed architetto nato a Zara all’inizio del XV secolo e morto a Sebenico nel 1473? No, quest’uomo non esiste in quei libri, perché il suo nome è stato croatizzato: Juraj Dalmatinac. La medesima sorte è toccata a uno dei maggiori pittori del cinquecento, Andrea Meldola, trasformato in Andrija Medulic. A Sebenico ed a Zara vi sono via intitolate a personaggi dal cognome Divinic che, talvolta, si presenta nella variante Difnik. Chi sono costoro? Franjo Divnic-Difnik nasconde Francesco Difnico, ovvero Difnicus nella versione latina. Fu uno storico delle vicende della Dalmazia del suo tempo, amico e parente dello storico di Trau, Giovanni Lucio. La medesima sorte è toccata a Giorgio Difinico, croatizzato in Juraj Divnic-Difnik, nato a Sebenico nel 1450 e spentosi a Zara nel 1530, dopo essere stato Vescovo di Nona. E’ stato trasformato in croato, col nome di Petar Divnic-Difnik anche il poeta Pietro Difnico nato a Sebenico nel 1525, comandante per quindici anni dei reparti cristiani in guerra contro i Turchi. Un’altra grande famiglia sebenicense che ha dato uomini illustri nel Cinquecento fu quella dei Verantius-Veranzio. Ma inutilmente sotto questa voce li cercherete nei dizionari enciclopedici croati; in essi si celano sotto il cognome, inventato, di Vrancic. Uno è il vescovo e umanista Antonio Veranzio (1504-1573), diplomatico, storico, archeologo, poeta e scrittore di viaggi, personalità di levatura europea che scrisse numerose opere in latino, quali: “De rebus gestis Hungarorum”; “De situ Transilvaniae, Moldaviae et Transapianae; “Elegiae”; “Otia”. L’altro è il fratello di Antonio, Michele Veranzio, autore di alcune opere storiografiche e letterarie, presentato in croato come Mihovil Vrancic Si è arrivati al punto da dichiarare croato perfino uno dei primi creatori del romanzo italiano, Gian Francesco Biondi, nato a Lesina sull’omonima isola dalmata nel 1574 e morto nel 1644 ad Aubonne, presso Berna, in Svizzera. Per gli storici della letteratura croata, che se ne sono appropriati, egli è uno “scrittore croato di lingua italiana”( sic); nelle enciclopedie viene indicato con il nome ibrido di Ivan Franjo Biondi- Biundovic. In una recente storia della Croazia, Dubravko Horvatic ha scritto che i primi scrittori croati di medicina vengono da Dubrovnik. Scrive, pure, che uno dei primi scrittori-croati di argomenti scientifici fu il raguseo Benko Kotruljevic-Kotruljic. Non è mai esistito! Sotto queste generalità, affibbiategli dai soliti falsificatori, si nasconde l’italiano raguseo Benedetto Cotrugli de Cotruglis, come egli stesso firmava le sue opere in italiano, ovvero Benedictus Cotrullus, quando si serviva del latino. Le stesse fonti croate ci dicono che gli antenati di questo uomo illustre, nato in una famiglia di mercanti, portavano il medesimo cognome italiano, sia pure alquanto modificato: Cotrulli, Cotrullo e Cotrugli. Ma fermiamoci ad una monografia di Antonio Bacotic del 1930 che ha per titolo “Benedetto Cotrugli da Ragusa, primo scrittore di aziende mercantili”, pubblicato nell’”Archivio della Dalmazia n. 5”. I primi testi nei quali il Cotrugli viene indicato come Kotruljevic risalgono, invece, al 1949. La moneta falsa coniata allora continua a circolare con 1’imprimatur della legalità. Un altro scrittore raguseo, il gentiluomo Serafino Cerva (1696-1759), autore di una celebre “Biblioteca Ragusina”, che è la prima enciclopedia della letteratura ragusea e dalmata, viene presentato come Serafin Crijevic dai suoi falsificatori costretti, peraltro, a tradurre l’opera del Cerva dal latino. Quando l’antologia dei “Latinisti croati” apparve, ci stupimmo della presenza in essa di poeti come Bola, Pasquali e altri che alla Croazia non appartenevano nemmeno territorialmente, essendo nati a Cattaro o nelle Bocche, dunque nell’odierno Montenegro. Ma la nostra meraviglia si trasforma in stupore e incredulità di fronte ad un’altra antologia apparsa nel 1993 col titolo “Stara knjizevnost Boke” (Antica letteratura delle Bocche di Cattaro) nella quale i curatori-saggisti croati Slobodan Prosperov Novak, Ivo Banac e don Branko Sbutega dichiarano espressamente che lo scopo del loro lavoro è quello di restituire alla letteratura croata gli scrittori delle Bocche di Cattaro, cioè di una fetta del Montenegro, perché quegli scrittori, essendo cattolici (sic) non possono essere serbo-montenegrini, ma croati! In questa antologia troviamo 43 autori nati nelle Bocche di Cattaro, di cui ben 22 non hanno lasciato una sola riga di scritto in lingua croata o serba, sicché è stato ingaggiato un manipolo di ben 11 italianisti per tradurre i loro testi dal latino e dall’italiano e inserirli nell’antologia. Per la precisione, in due casi le traduzioni sono dal latino e in tutti gli altri dall’italiano, scritti da Ludovico Pasquali-Pascalis, Giovanni Bola-Boliris, Giovanni Bolizza, Giorgio Bisanti, Girolamo Pima, Timoteo Cisilla, Giovanni Crussala, Giuseppe Bronza e Girolamo Panizzola; tutti innegabilmente italiani. Da circa ottant’anni - si cominciò timidamente con la prima Jugoslavia del 1920 -, via via in crescendo, continua il ladrocinio accompagnato dalla falsificazione dei nomi e cognomi italiani, ma a questo punto consideriamo una “curiosa” circostanza: la letteratura croata dalle origini e fino al XVI secolo è un susseguirsi di scrittori quasi esclusivamente dalmati. Viene spontaneo chiedersi come mai le arti e la letteratura croate non abbiano inizio in regioni dell’interno, mentre furono fiorenti prima del XVI secolo in Dalmazia, dove la letteratura, in particolare, si espresse in latino ed in italiano? I saggisti che, per arricchire la letteratura croata con opere scritte in latino e in italiano, commettono un furto alla luce del giorno vanno compatiti. Lo fanno mossi dalla consapevolezza che solo così facendo è possibile “fornire alla sposa una dote decente con cui presentarsi allo sposo”. Per concludere. Le prime scuole “cittadine” comparvero non a Zagabria, Osijek, Koprivnica, Varazdin, ecc., bensì a Zara e Ragusa, rispettivamente nel 1282 e 1333. La prima rete di scuole superiori non fu creata in Slavonia, nello Zagorje o in altre regioni, ma in Dalmazia, a cominciare dal collegio gesuita di Ragusa per finire con il seminario domenicano di Zara. Tutti gli intellettuali della Dalmazia, dal Duecento fino al Settecento e quasi anche a tutto l’Ottocento, frequentarono esclusivamente università italiane.
—G. Scotti
Note sulla slavizzazione dell'Istria e della Dalmazia
Nazionalismo slavo in Dalmazia
L’ozio forzato, che agli studiosi viene imposto dalla guerra presente, la quale ci ha tolto ogni commercio librario, ogni corrispondenza epistolare, ogni scambio di giornali e riviste con le nazioni occidentali, ci obbliga ad occuparci di piccole cose, di quelle che possono trattarsi cogli scarsi sussidi delle biblioteche del paese. Ma anche in queste cosuccie, che ci dovrebbero riuscire di svago — e se n’ha tanto bisogno — c’è invece motivo di disgusto, perché s’inciampa sempre nel solito nazionalismo croato, pronto a valersi d’ogni mezzo, per allargare le sue conquiste politiche, artistiche e letterarie a danno delle genti vicine.
Giova ricordare, e risalire un po’ ai tempi passati.
Quella tendenza non è di ieri: nasce nel secolo decimottavo, cresce nel decimonono, e non è morta neppure nel ventesimo. Nel decimottavo e nella prima metà del decimonono poteva essere giustificata dall’umile condizione, in cui si trovavano allora alcune discipline, specie la glottologia comparata; ma ora non può addurre giustificazione alcuna.
In que’ bei tempi la fu proprio un’ubbriacatura: alla vecchia ipotesi, che tutte le lingue fossero derivate da Babele e quindi dall’ebraico, si era sostituita l’altra, che provenissero tutte dallo slavo. Nè ciò era affermato soltanto dal volgo semi-letterato, ma anche da scienziati di qualche levatura, appoggiati da accademie e salariati col pubblico denaro. Di questi ultimi il Dankowsky, nel 1836, pubblicava il libro «Matris Slavicae filia erudita, vulgo lingua Graeca», e il Rollar, nel 1853, «Staroitalia Slavianska»; in cui pretesero dimostrare che il latino e il greco erano lingue figliuole dello slavo.
Anche da noi ci furono alcuni, che accolsero questa dottrina; ma quelli che l’accolsero con qualche riserva e l’usarono con qualche prudenza, vanno distinti da certi linguaiuoli, che ci lasciarono degli accostamenti etimologici deliziosissimi. P. e. Antonio Casnacich, da Ragusa, biasimato nella «Moda» di Milano (anno 1839, n.ro 71) di avere voltato alla meno peggio «Il cinque maggio » in slavo, cioè in lingua barbara, la difendeva, è vero, («Gazzetta di Zara» anno 1839, n.ro 86) coll’errore allora comune che lo slavo fosse la madrelingua che aveva dato le sueradicali alla lingua di Omero e di Virgilio; ma riconosceva che i Ragusei avevano parlato la lingua d’Epidauro (cioè il greco), e gli Spalatini quella di Salona (cioè il latino), contro l’opinione allora pure comune che gli llliri fossero stati slavi, e non discese mai a comporre di suo bisticci etimologici. Allato poi al Dankowsky e al Rollar, si possono mettere dei nostri F. M. Appendini e G. Capor: questi aveva sostenuto che l’illiro e lo slavo fossero identici; e quegli era andato a cercarne l’identità non solo nelle parlate della penisola balcanica, ma anche in quelle dell’Asia anteriore. L’ignoranza degli studi, che allora cominciavano, sulle lingue arie; la strana supposizione che lo slavo, lingua madre, fosse rimasto allo stato barbarico in confronto delle lingue figlie, non fecero loro comprendere che la relazione di madre e figlie era invece relazione di sorelle, e che la madre bisognava trovarla, non già nell’Asia anteriore, come aveva fatto l’Appendini, bensì nell’Asia centrale.
Ma i linguaiuoli!...
Dopo il Krreglianovic e il Cattalinich, che nelle loro «Storie della Dalmazia» avevano dato la stura ad etimi da far ispiritare i cani, la linguistica nostra precipitò così basso, da dare ragione non solo al Voltaire, che l’aveva battezzata per quella scienza, in cui le vocali si mutano a piacere e le consonanti non contano, ma anche a quel bello spirito, che da Nabucodonosor aveva fatto derivare violino. Di questi etimi strampalati era, più che altri, produttore fecondo un G. Giurich; ne infiorava la «Gazzetta di Zara», da cui abbiamo ricavato, come saggio, i seguenti.
Egli si mette un giorno in testa che nei nomi storico-geografici le desinenze -azia e -usici siano derivate dallo slavo muzi (allora si scriveva muxi) = uomini e da muzia (muxia, voce inventata da lui) = complesso di uomini. Perciò Dalmazia verrebbe da dagl (dalje) muxi!= avanti uomini; en avant, braves! — Vandali da Van-dagl (muxi) = — fuori, più lontano, uomini! e andarono infatti in un paese lontano, in Van-dagl-muxia, cioè in Andalusia, condotti da Genserico, cioè da Junsij-ris = giovane leopardo. — Sarmati è quanto Czarschi muxi — uomini sovrani, che abitavano la Sarmazia, cioè la Czarska muxia;così Vormazia (Worms) è Verlmuxia = paese degli Eruli (!). — Odoacre poi è Otto-czar = padre sovrano; i Rassiani, Russiani, Russi = uomini disseminati, da rassiat = disseminare'). Un anonimo, messosi sulla via del Giurich, trova che Bardileo, re illiro, è lo stesso che Berdilav— leone del monte; Scrdileo, altro re illiro, Sardilav — leone irascibile; Jehova = je ovo, Cioè quod est, hoc est il bibl. ego sum, quisum; sanscrito — sacrit — lingua secreta: Tracia, tardai = terci —correre-). E ci furono anche delle polemiche: il Giurich aveva detto che Jader veniva da jadriti = veleggiare; un altro lo rimbeccò e sostenne che derivava invece da Jadre (Andrea), come Peterzane da PietroZiani e Venieraz 0 Vigneraz da Venier). Ma la voce più tormentata fu Nabucodonosor, finché l’anonimo che aveva fatto correre i Traci, come il suo collega aveva disseminato i Russi, scoperse che valeva quanto Nam-Bogu-dano-tzar = Zar a noi dato da Dio; a cui un altro bello spirito, allievo forse del caffè Pedrocchi, sulla falsariga di quello che ne aveva tratto violino, contrappose la sudiceria dialettale Na-buco-da-nasar! E cotesti giochetti passarono anche in Italia: il Ciampi, annunziando nell’ « Antologia » di Firenze (anno 1847) l'opera del Dobrowsky «Institutiones linguae slavicae», si lasciò andare a raffronti etimologici senza capo nè coda. Lo stesso Tommaseo in un suo primo scritto su tale argomento: «Gli Sciti, gl’ llliri e gli Slavi» ammise l’universalità dello slavismo nell’Europa orientale e trovò p. e. che Scitaderivava da skitati = errare. E arzigogoli siffatti non sono finiti neppure ai giorni nostri, coll’aggravante che, se allora erano ingenuità perdonabili, adesso sono canagliate criminali. Il dr. Strohal in un suo studio sulla « Storia del diritto nelle città dalmate », uscito testé a Zagabria, piglia per slave molte voci, che sono invece di origine latina, rispettivamente italiana. «La „calletta“ o „sottovolto del Lulin“ », di cui trovò menzione in un libro zaratino, la interpretò per Lulina svod = il sottovolto del matto, perchè lesse alla slava Lùlin, e non già come pronunciamo noi Lulin, meglio Lolin. La quale voce da noi e nelle provincie venete è nome di persona, derivata da Lorenzo-, basti ricordare la Cappella de’ Lolini a Venezia, ove c’erano dipinti del nostro Andrea Meldola. Talarigi e Pappo, mutati arbitrariamente in Talaric e Popov,sono, viceversa, nomi di origine germanica: Talareich e Babo; tutti poi sanno che Tallarigo è un vecchio scrittore napoletano (« Gior. storico della lett. ital.», ann. II, pag. 196); Quchitto, divenuto Óukic,è il diminutivo dalmatico di zucca o zocco. Bucadeo, letto male per Butadeo, è il nome del famoso errante medievale, e non ha a che fare con Bonadicü. Griparius non è Griparijev, ma è l’aggettivo sostantivo di grippo (gr. lat. yQìnog, gryphus) — rete e barca peschereccia, e significa pescatore. Cosi Cuparus e Cuparius indicano un’arte, prima il fabbricante di giubbe, e poi per estensione il sarto; male quindi mutato in Čupar, e peggio accostarlo, in quanto all’etimo, a zupano = capo di un distretto. Non bisognava poi credere ad un vecchio cronacista ragusino che povulani valesse quanto poi-villani, cioè mezzo-villani; la voce deriva invece da populani, che altrove, a Capodistria p. e., si dicevano pure povolani, ora corrotto in paolani. Lexa non è Lesina,ma Lissa, esempio bellissimo di mutamento neolatino regolare di una iin posizione. Lat. Issa, con l’articolo concresciuto, doveva dare Lessa: la i restò, per influenza del dalmatico, invariata. All’incontro Lissa, isola di fronte a Zara che ha perduto la l ritenuta articolo, mutò regolarmente la tonica in e: Eso, ma nel dialetto rimane anche qui la i:Iso. E cosi di molte altre voci erroneamente battezzate per slave.
Di fronte però a tale slavismo esagerato, già nella prima metà del secolo decimonono, si posero degli eruditi di vaglia, decoro del nostro paese, degni di figurare in città d’importanza maggiore, che non
fossero le cittadine di Dalmazia: G. Ferrari-Cupilli a Zara, A. Fenzi a Sebenico, F. Carrara a Spalato, M. Capor e N. Ostoich a Curzota,
N. Niseteo a Cittavecchia, U. Raffaelli a Cattaro ed altri ancora. La «Gazzetta di Zara» dal 1832 al 1848 ci offre degli studi di grande eccellenza, messi insieme con squisita dottrina e con critica fine da quei dalmati egregi. Di molto prezzo furono le collezioni lapidarie e numismatiche da essi lasciate, le schede manoscritte che le illustrano, le monografie da loro messe insieme e rimaste inedite. Alcuni scrittori, che vennero dopo di loro e fiorirono nella seconda metà del secolo decimonono, si fecero conoscere nelle prime loro pubblicazioni coi lavori di quei valentuomini, che andavano superbi di rappresentare le idee e il progresso dello splendido periodo italo-francese. P. e. il Gliubich nel suo «Dizionario degli uomini illustri della Dalmazia» si è servito del materiale biografico, già raccolto e reso di comune ragione da loro, specie dal Ferrari e dal Raffaelli; mentre le sue prime monografie sulle iscrizioni e sulle monete greco-romane, stampate nei «Contoresi» dell’imperiale accademia a Vienna, derivano dal Niseteo e dall’ Ostoich.
Ma fra tutti i suoi comprovinciali, per conoscenze vaste e profonde, specie per franchezza e liberi sentimenti, emerge il Niseteo: nel primo suo scritto «Filologia patria» si oppone tosto alle teorie degli slavisti e nega loro che gli llliri sieno stati slavi, caposaldo di tutte le loro deduzioni. Gl’ llliri —insegnava il Niseteo ancora nella prima metà del secolo XIX — sono paralleli ai Celti, ai Baschi e agli Albanesi.
Come nella Spagna e nella Francia, dopo il dominio romano e le irruzioni barbariche, delle popolazioni antiche restarono i Celti e i Baschi, così non è meraviglia, se gli avanzi del valoroso e bersagliato popolo dalmata si fossero raccolti e rifugiati nelle montagne dell’Albania, e che perciò, trasportatasi colà con esso loro la lingua, andasse smarrita nella Dalmazia. E se ad estinguere questa lingua non fosse bastata la conquista romana, lo avrebbero fatto le orde degli Slavi, i quali, risparmiando l’Albania, innondarono la Dalmazia, devastandola ed incendiandola: anzi per somma sventura di quella provincia, vi fissarono la loro dimora, portando ignoranza e barbarie, dove prima erano civiltà e gentilezza. Si allontanano quindi dal vero coloro, i quali cercano in Dalmazia la lingua slava, prima ch’ella soggiacesse all’invasione del popolo di questo nome. Se gl’llliri fossero stati slavi, dovrebbe la Dalmazia offrire il più grande numero di voci slave nei nomi antichi; invece fra centinaia di nomi, rimasteci nelle iscrizioni latine, non ce n’è alcuno slavo.
Niseteo conosce già il lavoro classico del Larramendi sulla grammatica e sul lessico basco, che troviamo tuttora citato dai più illustri romanisti moderni, p. e. dal Diez e dal Körting. Anche il Tommaseo, che in un secondo scritto sul tema medesimo si era ricreduto, batte codesta via. Giustifica però gli slavisti, che cercavano nella lingua loro le origini d’altre più famose e letterate: volevano così rivendicarne la fecondità, la bellezza e la sapienza di fronte agli spregi lingiusti, di cui la coprivano gli stranieri. Una sola parola — egli conclude — basta a dar loro la verità e la credibilità, che non paiono avere: se invece d’origini parlisi d’affinità; e se — aggiungiamo noi — le casuali affinità di suono e di senso non si accolgano sempre come argomenti di identità etimologiche.
Ma chi da questo movimento, diremo così, filologico volesse dedurre un movimento politico slavo, forte, compatto, universale ad esso corrispondente, forse rischierebbe d ingannarsi. Il riflesso, che se ne riscontra nelle lettere e nelle arti italiane, fiorenti in Dalmazia nella prima metà del secolo decimonono, ci dà a divedere che il più delle volte si tratta, se non di Arcadia in ritardo, di romanticismo, allora comune a tutte le colte nazioni, e non già di nazionalismo. Infatti la massima parte dei letterati e degli artisti, che svilupparono soggetti slavi, sentirono italianamente; e se c’era un movente politico, tendeva desso a stringere in un solo fascio gl’Italiani e gli Slavi. Slavofilia quindi e non slavismo, estesa pure all’Istria, a Trieste e a Gorizia, che si rispecchiava oltre che nei giornali politici, nella « Favilla » di Pacifico Valussi a Trieste, e nella «Dalmazia» di Giovanni Franceschi a Zara.
Non appartiene a noi l’enumerare qui i letterati non dalmati delle provincie italiane dell’Austria, che svolsero in prosa e in verso temi slavi, e misero in scena produzioni d’argomento slavo; basterà ricordare Francesco Dall’Ongaro, che li rappresenta tutti. Di lui i nostri babbi sapevano a memoria «Usca», la ballata morlacca; e avevano applaudito nei teatri di Trieste ai « Dalmati », e in quelli di Milano e Zara, a «Marco Cralievich l’Ercole slavo», che il Filippi argutamente parodiava in «Ercole slavato»'. Ma egli era stato anche l’autore del Proclamarivoluzionario, diretto, il 10 aprile ’48, da Udine ai Triestini, in cui, fra le altre cose, diceva che gli Slavi erano all'Italia fratelli di sventura,e fra poco di gloria; e autore pure della relazione al governo provvisorio della Lombardia del 19 aprile, nella quale affermava, l’Istria e la Dalmazia essere italianissime. Scrivere su temi slavi, dichiararsi fratello agli slavi, si; ma, come la pensavano tutti gli altri suoi colleghi in arte e in politica, non sacrificare a loro quello che c’era d’italiano nelle due provincie, legate a Venezia per tanti secoli di affettuosa sudditanza.
Più che le manifestazioni politico-letterarie del giornale diretto da Q. Franceschi, sono per noi interessanti, quelle della «Gazzetta di Zara», fondata nel 1832 dal governo, dopo 22 anni dalla morte del «Regio Dalmata », pubblicato dal provveditore generale Vincenzo Dandolo sotto il governo franco-italiano, fregiata dell’aquila imperiale, portavoce della i. r. Luogotenenza della Dalmazia. Subito colpisce il titolo: «Gazzetta».
Perchè non come a Trieste: «Osservatore»? Quando la Gazzetta nel ’48, cessò di essere ufficiale, il governo si attaccò subito ad un Osservatore; ma prima Gazzetta, perché era quasi un secolo, che usciva sulle lagune la «Gazzetta di Venezia». Si pubblicavano alle volte in essa certi scritti e vi si davano tali giudizi, che poi adesso non sarebbero stati permessi a giornali ufficiali. Subito nei primi numeri avverte un corrispondente che nella campagna di Scardona (1832, n.ro 11), il viaggiatore troverà tutte quelle amenità deliziose, di cui è ricco il suolo italico, e in due articoli (an. 1832, n.ri 35-36) sulla «Letteratura italiana» a proposito delle poesie del Colleoni, c’è tanta Italia, da fare meraviglia che ce l’abbiano tollerata. In un altro articolo sullo stesso tema si chiama nostra letteratura e nostra lingua, la lingua e la letteratura italiana (n.ro 41). Il 28 marzo del 1834 erano arrivate a Nuova-York le fregate austriache Guerriera ed Ebe. Fece impressione —osserva la «Gazzetta» — che l’ufficialità fosse quasi tutta veneziana, e parlasse soltanto l’ italiano.
Ma allora l’i. r. Collegio dei cadetti di marina, che era a Venezia, aveva per lingua d’istruzione l’italiano; e tutte le navi da guerra, sino al ’48 portavano nome italiano. E ciò pareva naturale, perchè gli ufficiali e i marinai venivano quasi tutti dal Veneto, dall’ Istria e dalla Dalmazia.
Rispetto alle quali la stessa « Gazzetta » aveva lasciato dire nelle sue colonne che la Dalmazia era sempre stata un’appendice all’Italia (an. 1837, n.ro 30), un ultimo lembo dell’Italia, assieme all’Istria una provincia e per spirito e per coltura altamente italiana (an. 1845, n.ro 61), e Zara nella qualità, nelle attitudini, nel linguaggio della sua popolazione una piccola città d’Italia (an. 1842, n.ro 73).
Dinanzi poi alle meraviglie del Segato, che petrificava i cadaveri; dinanzi alle prove dell’Andervolti che cercava di dirigere gli areostati con la forza del vapore: dinanzi alle nuove armi da fuoco del Pierantoni, che in ottanta secondi faceva venti colpi di fucile e sette di pistola, e con un obusiere lanciava 2350 palle, la «Gazzetta» (an. 1838, n.ro 45) esclamava: «No! non sarà mai che rimanga lungamente neghittoso il genio italiano, perchè è desso il prediletto del Creatore. E se alcunavolta si nasconde o sembra starsi assopito, egli è per ricomparir più sublime e brillar su questa terra, che ha in sè la scaturigine delle umanecognizioni, e che con unico esempio già sostenne l’impero del mondo».
E così avveniva che M. Casotti da Traù, estensore della «Gazzetta» dopo Agostino Brambilla, che era stato nominato (1836) professore a Verona, pubblicasse due romanzi di soggetto slavo «Milienco» e il «Berretto rosso»; mentre sull’autorità del Porfirogenito si sforzava nel giornale ufficiale di dimostrare che gli Avari erano slavi, per attribuire a questi gli incendi e le devastazioni di quelli (an. 1840, n.ro 80). E così F. Seismit-Doda, ragusino, collaboratore della «Gazzetta», esordiva tra noi con un dramma d’intonazione slava «Marco Marulo», recitato pure al Mauroner di Trieste; ma scriveva anche l’ «Inno» bellissimo alla «Dalmazia», pieno di ricordi del passato e di speranze per l’avvenire, stampato prima nella « Gazzetta », declamato a Zara e a Trieste dall’attrice Ardelia Arrivabene (an. 1847, n.ro 14), e finiva poi in Italia, ministro delle finanze, dopoché aveva cooperato nel ’48 alla difesa di Venezia. Un nostro concittadino, N. Battaglini, collaboratore pure della «Gazzetta», metteva in scena una commedia incolore « Maria» («Gazzetta», an. 1845, n.ro 47), ma poi pubblicava nella «Gazzetta» stessa (an. 1847, n.ri 5-7) delle scene dalmate sulla caduta della Repubblica, di cui una slava «Jela» ne faceva l’apologia, e chiudeva i suoi giorni a Venezia, dopo avere data vita e ordine all’odierno museo archeologico di Murano.
Ma questa slavofilia non si appalesa forse in nessuno con tanto contrasto, quanto nel pittore Francesco Salghetti da Zara. Non parliamo dei quadri di soggetto slavo, che gli furono commessi dal vescovo Strossmayer, di quelli bensi eseguiti di sua elezione nei primi anni della sua vita artistica. Questi sono: «La fanciulla a cui ignominiosamente togliesi di capo il berretto rosso», che ha poi suggerito al Casotti il romanzo omonimo da noi accennato più su, « Il bardo morlacco » e «La risurrezione di re Dusciano». Quest’ultimo, che commentava una poesia del Preradovich, scritta nel ’48, aveva un significato politico chiaro abbastanza: il ritorno di quel re in Serbia, per ricondurla alla vittoria e alla libertà. Preludeva al «Giuramento dei re di Croazia, Bulgaria e Serbia», che avrebbero cacciato gli stranieri dalla Balcania.
Ebbene, a tali esercitazioni, diremo così accademiche, stanno di contro due lavori, di propria elezione, fatti con sentimento di patriotta italiano.
Essi sono: «S. Ambrogio, che rimprovera a Teodosio la strage di Tessalonica e gli vieta l’ingresso al tempio» - «Lina fanciulla che piange sul campo di battaglia la morte dell’ lamato». Il primo quadro insieme ad altri fu accolto all’esposizione di Milano nel ’38, aperta per Francesco I, che vi era andato a prendere la corona del regno Lombardo-Veneto. II Tommaseo in quell’occasione scriveva al Salghetti (23 agosto):
«Piacemi che al momento dell’incoronazione abbiate esposto a Milano il s. Ambrogio scacciante l'incoronato. Perchè non intesero, permisero».
Ma forse intesero a fatto compiuto: la «Gazzetta privilegiata» di Milano (15 settembre) pubblicava un trafiletto velenoso contro tutte le tele, messe in mostra dal Salghetti, e non nominava il s.Ambrogio. Il soggetto del secondo quadro era veramente «La battaglia di Gavinana, la morte del Ferruccio e la fine della libertà fiorentina». Una fanciulla prostrata a terra, posa la mano sull’abbattuto stendardo di Firenze, e abbraccia l’elmo del Ferruccio; negli spicchi dei quattro angoli, c’erano quattro mostri allegorici, ciascuno con lo stemma dei quattro personaggi, che erano stati causa dell’eccidio di Gavinana: papa Clemente VII, Malatesta Baglioni, Alessandro de’ Medici, Carlo V. Alla Filotecnica di Trieste, ove questo quadro'era stato esposto nel ’41 insieme"al «Bardo morlacco», pareva che nessuno avesse badato a quei mostri e a quegli stemmi; ma forse furono notati, perchè la Direzione della Filotecnica, che aveva preso una deliberazione onorifica per il Salghetti, improvvisamente ebbe a ritirarla. Aveva scelto il «Bardo morlacco», per ricavarne una stampa, da dare in dono ai soci, a tenore dello Statuto. Invece, con grande meraviglia del Salghetti e di altri, mutò divisamento; preferì il quadro di un tedesco, che aveva preteso di raffigurare l'Italia in certi briganti degli Abruzzi, che assalivano alcuni viaggiatori inglesi i quali con grande valore si difendevano.
Questo gruppo inoltre di Dalmati eletti, amorevoli quanto si voglia verso gli Slavi, non sopportava che si oltraggiasse Venezia, e le difese della Serenissima rendeva pubbliche nel foglio ufficiale. Antonio Fenzi, a chi aveva detto che il Sarpi avesse consigliato d’immiserire la Dalmazia, sradicandone i gelsi e gli ulivi — stupida accusa, ripetuta anche ai nostri giornil) — rispondeva («Gazzetta di Zara », an. ’42, n.ro 69), rilevando che non era tutto tenebre nei tempi andati: «I ricordi di fra Paolo non cospirarono a nostro danno. Imperciocché quelli che possediamo, nulla parlano particolarmente della Dalmazia. Ma credasi pure ciò che il volgo spaccia, è certo però che la Veneta Repubblica non seguiva i consigli di lui, essendone una prova la legge agraria benefica e previdente, anzi l’unica forse per una popolazione nomade, non frenata ancora dalla forza morale, non premurosa ed antiveggente, non accostumata ad uno stabile sistema di politica economia». Alfredo Frisiani, contro alcuni giudizi, dati dal Cattalinich nelle sue «Memorie», osservava («Gazz. », an. 1845, n.ro 93): «Che nell’amministrazione il veneto governo non fosse alla Dalmazia sommamente giovevole, possiamo crederlo. La nazione per altro a quel governo affezionata era assai, e questo prova che il giogo di esso non era tirannico... Pochiufficii, pochi magistrati importavano tenui spese, tenui aggravi pubblici alla nazione. Quando Venezia fu ceduta dagli stessi suoi figli nel terribile zorno del dodese, i fedeli Schiavoni (sotto il qual nome si comprendevano per la maggior parte dalmati) non volevano cedere ad alcun patto; unitisi in orde giravano armati per le vie di Venezia proclamando il loro S. Marco, e invano per due giornate chiesero alla moriente sovrana un campione che alla testa di essi rivendicasse i suoi diritti all’abbandonato Leone». E, dopo aver ricordato il noto episodio delle bandiere venete calate a Perasto, conclude: «Un governo che fu tristo, tirannico, improvvido non finì mai fra simili dimostrazioni d’amore». Bellissimo l’articolo del Tommaseo Pii istituti, riportato dalla «Gazzetta di Venezia» nella nostra (an. 1845, n.ro 57), con cui ribatte «le parole dure che italiani e stranieri confondono contro il veneto nome»; e bellissimo uno pure di Francesco Carrara (ibid., anno 1847, n.ro 72) intitolato Carattere dei dalmati, nel quale rilevava cotesto carattere dai vicendevoli legami d’affetto e di fede che avevano stretto per tanto tempo i dalmati a Venezia. Ricordava, fra le altre cose, il discorso del Foscarini a favore della Dalmazia; l’elogio, che dei dalmati fece il Goldoni nella «Dalmatina» e nelle sue «Memorie» (lI, 34); le lagrime, sparse a Zara e a Perasto sulle bandiere venete, tolte dagli stendardi alla venuta degli austriaci. Ricordava che Fabio Mutinelli aveva dedicato i suoi «Annali di Venezia» agli schiavoni: «A voi, che soli fra tutti nell’estremo caso di Venezia, consegnando altrui il vessillo di s. Marco, sospiratamente baciato ed abbracciato l’avete, prorompendo in pianto dirotto, a voi questo libro giustamente appartiene». Ricordava che un povero prete schiavone, suo conoscente, conservato gelosamente un di quei venerati vessilli, lo dispiegava ogni anno nel di di s. Marco e, banchettando condue amici della giovinezza, bagnava le labbra al leone col vino di Cipro.
Questa digressione valga a dimostrare che il nazionalismo slavo in Dalmazia non è anteriore al secolo decimottavo, che non è stato mai generalmente inteso, e che sono il più delle volte esagerate e senza fondamento le rintegrazioni etimologiche, fatte posteriormente dagli slavisti. Sicché, tornando all’argomento di questo scritto, se è vero, per testimonianza di tutti quelli i quali hanno parlato del Fortunio, che egli era schiavone, è vero altresì che nessuno, in mezzo a tanti slavici amori, ha mai rilevato, essere la voce <Fortunio> traduzione di Srica, che vale fortuna. Il primo ad affermarlo fu il dr. M. Srepel nella monografia «Hrvat prvi gramatik talijanskoga jezika » (Un croato, primo grammatico della lingua italiana), pubblicata nel «Rad» di Zagabria, voi. 140, pag 1 e segg., an. 1899. E come l’ha saputo? L’ha semplicemente immaginato, mettendo insieme questo ragionamento: Nel nome Fortunioc’è la parola fortuna, il Fortunio era schiavone, di conseguenza gli Schiavoni erano croati, dunque il Fortunio si sarà chiamato croatamente Srica, che poi tradusse in fortuna, da cui formò Fortunio. Ma in questo ragionamento c’è una premessa falsa: Venezia, è vero, chiamava Schiavoni gli abitanti dell’Adriatico orientale, ma non tutti quegli abitanti detti Schiavoni erano croati, o slavi in generale. E così a torto lo Srepel ripete che il Meldola era un Medulich e, nuova scoperta, che il Carpaccio era un Krpac, sempre col pretesto che il Meldola sarebbe stato uno schiavone della Dalmazia, e il Carpaccio dell’Istria.
Il pensiero di Georges Perrot su Trieste
L'accademico francese Georges Perrot descrisse Trieste come una città "tutta italiana", da associare alla madrepatria in numerosi settori.
L'eccidio di Malaga Bala
Imprigionati, deportati, avvelenati, torturati ed infine tagliati a pezzi: fu questo il tragico destino di ben dodici giovani Carabinieri Reali, catturati nel 1944 dai partigiani comunisti sloveni e italiani alle Cave dei Predil, nell’alto Friuli.
I Carabinieri Reali, a quel tempo sotto il Comando tedesco, costituivano un presidio a difesa della centrale idroelettrica di “Bretto di sotto”, oggi territorio sloveno, che produceva energia per l’intera popolazione della vallata e per la miniera di Cave del Predil, appunto, situata a 10 chilometri da Tarvisio.
A loro era stato chiesto, dopo l’8 settembre 1943, di rimanere al loro posto, al fianco delle popolazioni, per assicurare la regolarità delle funzioni civili (ordine pubblico e polizia giudiziaria) e delle funzioni militari (protezione degli impianti industriali e di pubblica utilità).
La vigliaccheria partigiana delle bande armate comuniste in quel periodo si accaniva contro obiettivi militari tedeschi mediante agguati e attentati, ben sapendo che ciò avrebbe scatenato le rappresaglie naziste (consentite dai codici di guerra) contro le popolazioni civili.
Dopo aver subito gli attacchi dei “valorosi” partigiani comunisti, che prima si rendevano responsabili delle inevitabili rappresaglie e poi si davano alla macchia, il commissario germanico Hempel richiese al Comando militare la costituzione di un Distaccamento fisso di Carabinieri a protezione della centrale idroelettrica.
Il 23 marzo 1944 però i partigiani assassini di Tito misero in atto un piano criminale, volto a seminare terrore e a destabilizzare quei territori su cui il comunismo titino voleva estendere i suoi artigli, pianificandolo in due fasi.
Dapprima presero in ostaggio il Vicebrigadiere Dino Perpignano, comandante del distaccamento, e il Carabiniere Attilio Franzan, catturandoli mentre rientravano dal paese e si dirigevano verso gli alloggiamenti.
I due partigiani Ivan Likar, detto Socian, e Zvonko, costrinsero i due prigionieri sotto la minaccia delle armi a pronunciare la parola d’ordine all’ingresso del Presidio, riuscendo così a penetrarvi con facilità insieme agli altri comunisti assassini che nel frattempo avevano circondato la caserma.
Una volta entrati i partigiani catturarono tutti i Carabinieri, sorprendendoli in parte addormentati, e dopo essersi abbandonati ad un criminale saccheggio dei locali, li costrinsero a portare in spalla tutto il materiale trafugato (armi, munizioni, vestiti, cibo, attrezzi, e turbine) mentre a piedi si dirigevano verso la salita che conduceva al Monte Izgora (circa mille metri di altitudine), poi scendendo verso la Val Bausiza, e infine risalendo ancora verso l’altopiano di Bala, appena fuori Tarvisio.
I dodici Carabinieri furono così deportati nel luogo in cui avrebbero trovato la morte per mano assassina dei vili partigiani comunisti, dei quali ancora oggi le squallide Associazioni come l’Anpi ne commemorano le gesta, a ribadire il loro disprezzo per la Democrazia e i diritti umani.
La sera del 24 marzo 1944 i partigiani decisero di effettuare una sosta, e di pernottare sull’altopiano di Logie, (853 metri di altitudine), rinchiudendo i prigionieri in una stalla.
Quella sera la ferocia comunista e la vigliaccheria partigiana, che hanno sempre contraddistinto l’operato degli “eroici” fautori della cosiddetta “resistenza”, si manifestò con sadico cinismo.
Ai militari venne infatti servito un pasto caldo, costituito da un minestrone nel quale era stata aggiunta soda caustica, varechina e sale nero, nella consapevolezza che i prigionieri affamati avrebbero inconsciamente mangiato tutto ciò che era nel piatto.
Il minestrone avvelenato fu preparato dalle donne della famiglia di Lois Kravanja (Cravagna), uno dei partigiani del commando criminale, composta esclusivamente da elementi comunisti titini, ben felici di esprimere così il loro odio irrazionale e sadico.
Dopo breve tempo i Carabinieri avvelenati iniziarono a contorcersi dal dolore fra atroci spasimi, urlando e implorando i loro carnefici in una lunga agonia che si protrasse per diverse ore.
Il mattino seguente, il 25 marzo 1944, nonostante il fatto che i prigionieri fossero stremati dalla dissenteria provocata dall’ingestione di sale nero e in preda a dolori lancinanti causati dall’azione necrotica della soda caustica, che nel frattempo aveva ustionato faringe, esofago e stomaco, vennero obbligati dai “valorosi” partigiani comunisti titini a marciare fra atroci sofferenze verso Malga Bala, la destinazione finale in cui sarebbero stati uccisi.
I prigionieri stremati e consumati dalla febbre, quasi tutti ventenni (e mai impiegati in altri servizi tranne quello a guardia della centrale, cui erano stati sempre preposti), vennero sottoposti allo sfrenato sadismo che caratterizza l’operato degli aguzzini comunisti.
Il Vicebrigadiere Perpignano venne afferrato per primo e spogliato, poi i partigiani gli conficcarono un legno ad uncino nel nervo posteriore di un calcagno, e lo issarono con una corda legata ad una trave a testa in giù, come se fosse un quarto di bue, infine non contenti gli squallidi assassini lo incaprettarono e lo finirono a calci in faccia e in testa.
L’incaprettamento, per chi non lo sapesse consiste nel legare mani e piedi dietro la schiena, facendo passare la corda attorno al collo e provocando lo strangolamento a causa dei movimenti dell’incaprettato stesso.
Nel frattempo gli istinti più selvaggi e brutali dei partigiani palesarono la loro indole criminale con comportamenti inumani, come quello di colpire i prigionieri con violente picconate su ogni parte dei corpi.
I macellai partigiani tagliarono i genitali ad alcuni prigionieri, ancora vivi, e glieli conficcarono in bocca, dimostrando un disprezzo che va al di là dell’umana comprensione e proseguendo la tortura mediante la frantumazione degli occhi e l loro asportazione dalle orbite.
Ad altri prigionieri venne aperto il cuore a picconate, oppure veniva cucita la bocca con filo di ferro dopo averli castrati.
Al Carabiniere Primo Amenici venne aperto il cuore per conficcargli dentro la fotografia dei suoi cinque figli che teneva nel portafoglio.
Dopo la feroce mattanza i Carabinieri furono legati col filo di ferro e trascinati come sacchi sotto un grande masso, e ricoperti sommariamente di neve.
I corpi straziati furono rinvenuti casualmente da una pattuglia di militari tedeschi della Wehrmacht la sera del 28 marzo 1944, e recuperati.
Oggi i resti mortali di queste vittime del comunismo partigiano riposano, nell’artificioso oblio imposto dai seguaci di Togliatti e dalla compiacenza politica istituzionale, nella torre medioevale della Chiesa a Manolz di Tarvisio, le cui chiavi sono custodite dalle suore di un vicino convento.
I resti di Dino Perpignano di Domenico Dal Vecchio, e di Antonio Ferro sono stati invece riportati nelle località di provenienza dalle rispettive famiglie.
Nel 2018 il Generale dell’aeronautica militare Mario Arpino, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi ultra ottantenne, ha ricordato l’eccidio testimoniando quanto segue:
“Ero un ragazzino, avevo sette anni nel 1944. Ho visto quei corpi, ancora me li ricordo.
Stavamo passando da lì, appena fuori Tarvisio, con mio padre.
Eravamo sulla moto, io sul seggiolino dietro.
Non guardare, non guardare, copriti gli occhi — mi disse mio padre. Ma non lo ascoltai.
Erano ghiacciati, denudati, i lividi degli scarponi, forse li avevano finiti a calci.
Uno aveva ancora il manico spezzato di un piccone infilzato nel petto, un paio la bocca cucita con il filo di ferro”.
 |
Libro: Dietro gli scogli di Zara di Nicolò Luxardo De Franchi
Il tenue filo della speranza che si alterna al disinganno percorre il racconto del dramma dei fratelli Nicolò e Pietro Luxardo, prestigiosi imprenditori ed esportatori di spicco della vita politica e civile di Zara, vittime degli avvenimenti che seguirono all'occupazione jugoslava dei territori dalmati nel 1944.
Sullo sfondo di una città martoriata dalla guerra, i destini dei due protagonisti si sviluppano secondo un imperscrutabile disegno, che culminerà nell'assassinio di Nicolò e della consorte Bianca per mano di ignoti partigiani jugoslavi e nella misteriosa scomparsa di Pietro.
È il filo della speranza a guidare gli sforzi che per lunghi anni la famiglia Luxardo compie per conoscere la verità sulla sorte dei propri cari, vagliando pazientemente ogni risposta ufficiale delle autorità interpellate. Nel labirinto di ipotesi che viene così costruendosi, il lettore è poco a poco coinvolto e spinto - quasi come in un giallo - ad abbracciare la più verosimile, aderendo al destino di uomini che la narrazione trasforma via via in figure corali, specchi di eventi condivisi da una moltitudine silenziosa.
Una storia più vasta fa eco a quello del "signor Piero" e del "signor Nicolò": è quella di un'intera città, che si stringe attorno all'austero palazzo del Barcagno, dietro quegli scogli che raccontano il dolore di un'intera popolazione.